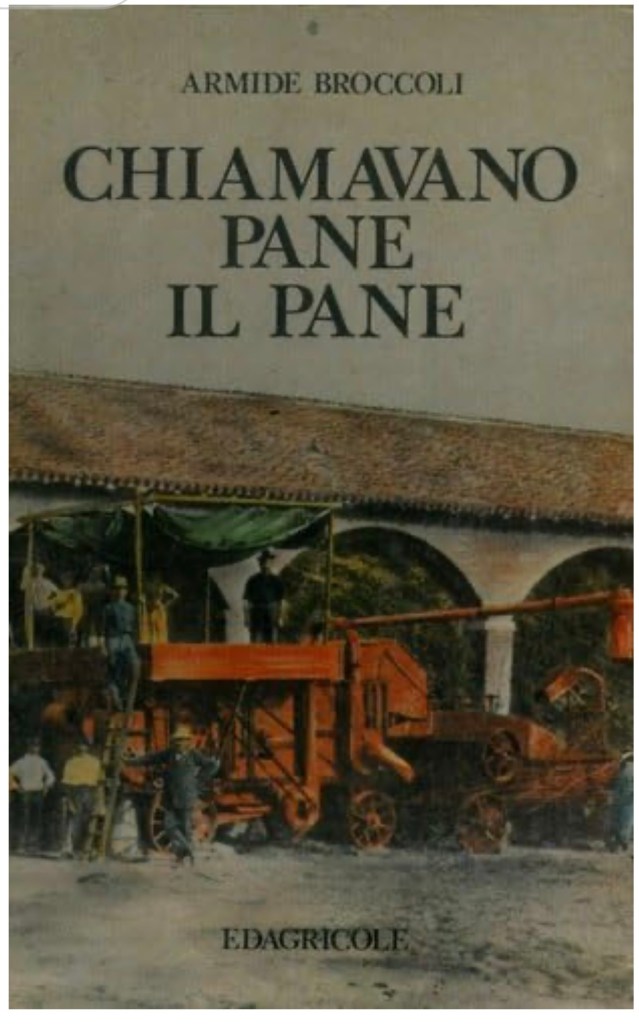Ci sono libri datati che risultano superati nei fatti. Ciò nonostante, leggerli può rivelarsi estremamente interessante. Quello di cui parlano non è ‘nuovo’. Ma, proprio perché è superato, può contribuire a una lettura critica del nostro presente. Soprattutto perché il nuovo ha portato con sé il diffondersi di una generale superficialità nel rapportarsi alla società in cui siamo immersi e, con essa, all’incapacità piuttosto diffusa di elaborare un pensiero critico sulle cose.
Un libro datato costringe a fermarsi, a riflettere, a interrogarsi.
Così, quando mi capita tra le mani un libro di questo tipo lo tratto come un piccolo tesoro da custodire. Solitamente, quando il libro in questione tratta, direttamente o indirettamente, questioni antropologiche e sociali, diviene un terreno di indagine privilegiato per comprendere come e quanto è cambiato il mondo in circa cento anni, con una accelerazione che non ha avuto precedenti e una ricaduta che può rivelarsi devastante per l’intera umanità nei prossimi decenni.
La prima cosa che mi colpisce è la frase di un entomologo e naturalista francese, Jean Henry Fabre1 (1823 – 1915), utilizzata come epigrafe, ad apertura del volume:
“La storia celebra i campi di battaglia dove incontriamo la morte, ma sdegna di parlare dei campi arati dei quali viviamo, sa i nomi dei bastardi dei Re ma non può dirci l’origine del grano. Queste sono le vie dell’umana pazzia”.
Mi sembra una buona chiave di accesso alla lettura.
Il libro si intitola Chiamavano pane il pane ed è stato pubblicato nel 1979 per i tipi della casa editrice Edagricole, specializzata in testi su questioni di agricoltura.
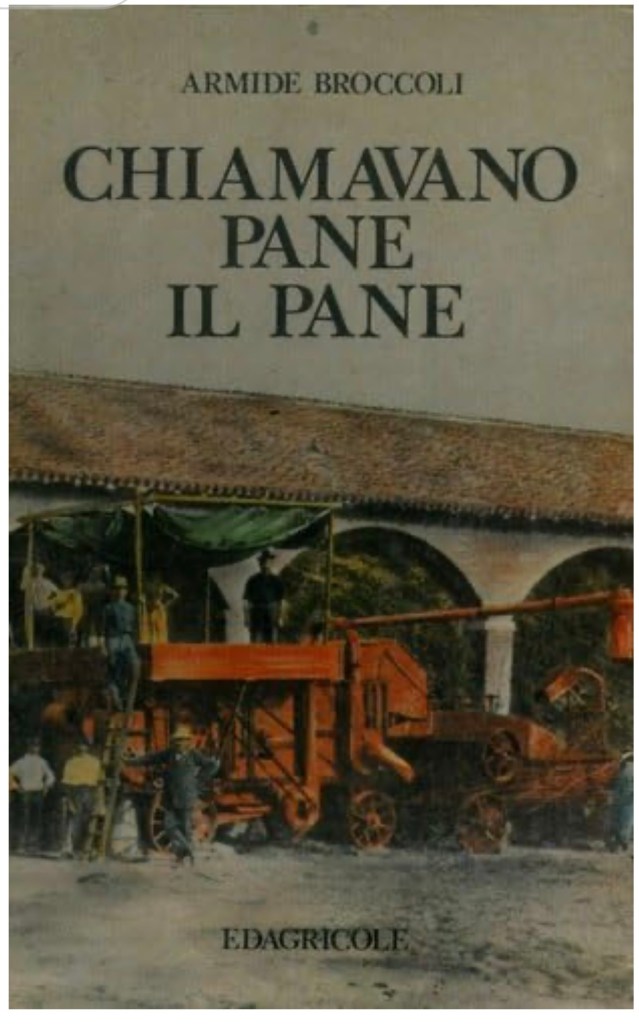
Sull’autore, Armide Broccoli, trovo poche notizie in un sito che raccoglie fatti e personaggi di Bologna e provincia: è nato nel 1926 a Castenaso, ha ottenuto la licenza elementare, è stato partigiano dal 15 aprile 1944 al 21 aprile 1945, ha lavorato la terra
Non ho trovato altro.
Di cosa parla il libro? Di lavoratori della terra, di coltivazioni, metodi e strumenti di lavoro, di strutture sociali e lavori contadini; parla della famiglia contadina e dei lavori artigianali connessi alle attività agricole.
Per certi aspetti è una sorta di summa dedicata alle attività contadine e al come e perché tali attività si siano trasformate nel tempo, in concomitanza con il diffondersi della meccanizzazione, dei prodotti chimici e dell’agricoltura intensiva. Una particolare attenzione è posta sulla questione della mezzadria, il contratto agrario diffuso fino a metà e oltre del secolo scorso nelle campagne italiane. Nel 1964 una legge ha vietato di stipulare nuovi contratti, anche se continuarono a rimanere in vigore, salvo essere sostituiti da un contratto di affitto con una legge del 1982.
Per moltissimi aspetti è un testo ampiamente superato.
Ma, proprio per gli effetti delle trasformazioni che hanno interessato l’agricoltura, dovrebbe essere riletto e riconsiderato. I cambiamenti sono stati tali e tanti da averci fatto perdere il contatto con la realtà della terra fino perdere cognizione della provenienza dei prodotti agricoli, limitandoci alla scelta della confezione sul banco del supermercato. Spesso senza che si sappia in quale stagione matura un frutto o una particolare verdura. Insomma, questioni tanto importanti da meritare tutta la nostra attenzione (e la rilettura di un libro come questo, se ci capita tra le mani).
Naturalmente, non ha molto senso scrivere la recensione di un libro che, se ancora si trova, è disponibile forse in pochissimi esemplari, in qualche libreria antiquaria o in polverose biblioteche di famiglia.
Non è detto, però, che non sia interessante proporne qualche brano, come spunto su cui riflettere, magari partendo da un’attività collaterale a quella agricola, appannaggio della donna, come altri lavori nell’economia domestica, improntata all’autoproduzione di tutto ciò che serviva per il fabbisogno familiare: la tessitura (per la quale si utilizzavano le fibre derivate dalle piante che si coltivavano, la canapa in particolare, o la lana delle pecore che si allevavano). Il primo riferimento alla tessitura si trova a p. 15, a proposito dell’abito:
“A fare il contadino c’era questo di positivo; un vestito durava tutta la vita, perché le occasioni per metterlo erano limitate al Natale, alla Pasqua e poco più. Quattro-cinque volte all’anno in tutto. Erano dei forti consumatori di abiti da lavoro, di lana per l’inverno e di rigatino in estate, frutti entrambi di un artigianato domestico razionale ed efficiente. Lei ne sapeva qualcosa in proposito; filare tessere cucire e cucire, tessere e filare senza sosta ad un ritmo incalzante. Già quando il pastore portava la lana di pecora doveva iniziare col lavarla, poi cardarla e filarla prima di passare dall’ordito e alla tessitura. Ne otteneva delle pezze spesse e resistenti come il cuoio con le quali il sarto confezionava giacche e pantaloni. Gli uomini indossavano quegli indumenti ai primi di novembre e li smettevano in aprile per ripararsi dai rigori invernali quando stavano nei campi a potare o fare altri lavori. Ciascuno ne aveva due capi, uno da adoperare tutti i giorni e l’altro da mettere quando andava via. Quelli estivi invece erano di cotone, più leggeri quindi e li chiamavano rigatino, perché tessuti a righe bianche e turchine. Bisognava acquistare matasse di cotone, colorarne una parte poi, durante la tessitura, fare attenzione ad alternare i colori”.
Ritorna poi a pagina 60, per parlare di biancheria (ma anche di ortaggi ed erbe):
“L’aspetto più sorprendente della reggitrice casalinga (arzdòura 1) era il suo carattere, quel suo modo disinvolto e paziente, tutto campagnolo, di affrontare i problemi, l’amore e l’impegno che metteva in ogni lavoro. Nella casa, ad esempio, non doveva curare solo l’alimentazione, ma teneva anche la chiave dell’armadio della biancheria che apriva quando c’era il cambio nei letti per il bucato. Controllava il logorio di lenzuola, federe, asciugamani, asciugapiatti, dei tessuti di lana e di rigatino – tutta roba che si consuma con un nulla – diceva sospirando – e faceva le previsioni sia per le sostituzioni sia per le doti dei figli. Non c’erano alternative: i rifornimenti familiari richiedevano duecento braccia di tela all’anno e si riusciva a raggiungere quel traguardo filando e tessendo anche la notte. La donna doveva andare nel campo a raccogliere gli ortaggi, piselli, patate, zucchine, radicchi, e nei periodi adatti tagliava le erbe medicinali che poi seccava al sole su dei graticci. Appena pronte le metteva in sacchetti di tela bianca sistemati su una scansia del granaio. La camomilla e le altre erbe emanavano un profumo intenso, penetrante, che si diffondeva nelle camere, lasciando scie buone che deliziavano l’olfatto”.
Giunta all’ultimo capitolo di Chiamavano pane il pane di Armide Broccoli, posso azzardare qualche parola per definire di che tipo di testo si tratti. Non è facile inserirlo in una categoria.
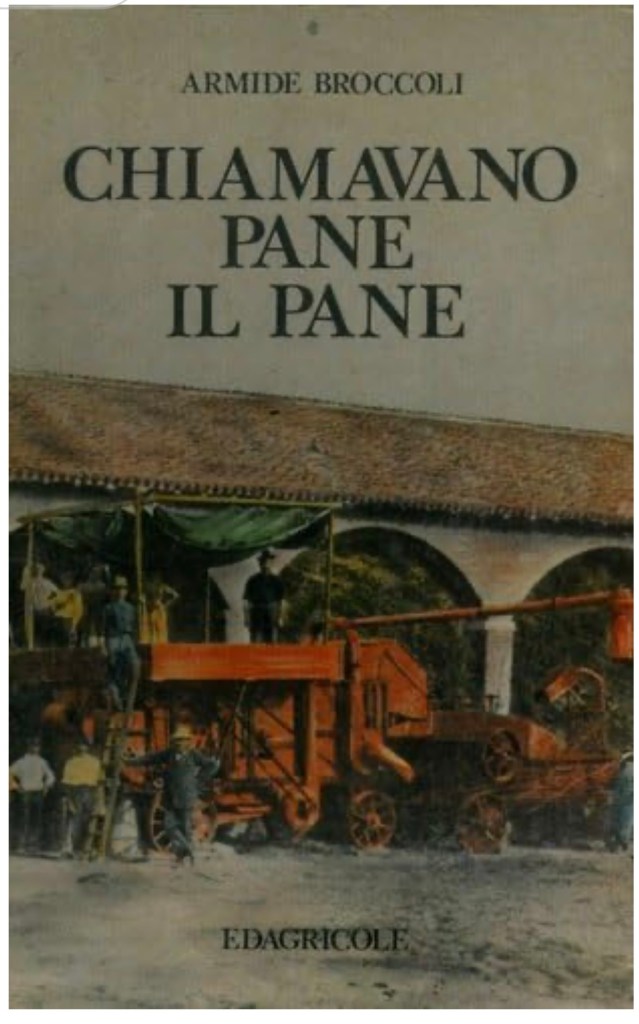
Sicuramente è un’opera di narrativa. Racconta infatti la storia di una famiglia contadina, tra il 1901 e il 1918. Ma la storia di famiglia recupera la storia degli antenati, risalendo fino al 1820, ossia all’inizio delle trasformazioni nel mondo dell’agricoltura grazie all’apparizione delle prime macchine. Diventa quindi una narrazione corale attraverso il tempo.
La coralità caratterizza anche la narrazione relativa al periodo centrale (1901/1918).
C’è infatti la famiglia. Ma attorno alla famiglia e al suo mondo c’è tutto un brulichio di altre persone che ruotano attorno ai lavori dei campi, fino a spingersi in città. Anzi la novità, a partire dal 1911, è proprio rappresentata dal contatto tra città e campagna: la nuova moda della ‘scampagnata’ per i cittadini, la domenica alla scoperta della città per i giovani delle campagne.
C’è ancora molto altro nel racconto. La narrazione diviene infatti occasione per spiegare tutto ciò che ha a che fare con il mondo contadino: le piante, gli animali, le coltivazioni e le tecniche, gli attrezzi e i lavori artigianali, i lavori stagionali, le tradizioni e le novità, le ricette, la vita quotidiana, le stagioni e il paesaggio. Narrazione, parti descrittive e spiegazioni si intrecciano continuamente ed è frequente il ritorno sugli stessi argomenti – quasi un ritorno ciclico, come quello delle stagioni!
Per molti aspetti è una narrazione epica con tratti di un’ “enciclopedia del mondo contadino”. Esattamente come l’epica di Omero (non quella eroica dell’Iliade, ma quella dedicata all’avventura del ritorno, l’Odissea), filtrata dal poema ‘agricolo’ di Esiodo.
Le ripetizioni non guastano. La narrazione deve (doveva/dovrebbe) avere una valenza formativa.
Così non sorprende che il cuore dell’ultimo capitolo contenga una sorta di ‘storia al femminile’ in cui l’autore ripercorre la vita di una donna, dalla nascita alla vita adulta. Si intitola Cataclismi. Si apre con lo scoppio di una guerra che travolge tutto e tutti. Si chiude con la morte di due figli, un garzone e una ragazza divenuta quasi figlia adottiva per l’epidemia di ‘spagnola’. Era il tempo delle suffragette. Le donne delle campagne italiane non ne sapevano nulla. Per la verità, neppure gli uomini.
Il risultato è una storia al femminile molto datata di cui peraltro vale la pena parlare, se non altro perché da quelle donne ci separano poco più di cento anni (mediamente, quattro generazioni!).
Il contenuto è superato ma fondamentale. Può essere il punto di partenza per riflettere sui cambiamenti, sulla loro velocità e, soprattutto, sulle conseguenze che hanno avuto a livello di produzione e di effetti sulla vita, sul lavoro, sull’ambiente. Può essere un’occasione per rallentare e riflettere sul mondo che abbiamo voluto.
Non si tratta di nostalgia: non c’è spazio per la nostalgia nella narrazione. Si tratta di consapevolezza.
NOTE
1. Di Jean Henry Fabre è recentemente uscito per i tipi Adelphi, il primo volume di Ricordi di un entomologo, originariamente apparsi tra il 1879 e il 1907 e pubblicati per la prima volta in italiano nella collana I millenni (Einaudi) nel 1972.
2. La lingua usata da Armide Broccoli è un italiano fortemente caratterizzato da termini dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato tessile, ecc., spesso alternati alla variante dialettale di area bolognese. L’“arzdòura” è uno di questi termini, quello che percorre tutto il testo ed è, forse, il più significativo. Se ne trova la spiegazione, originaria e attualizzata, in un articolo di Serena Bersani in Tessere.org https://tessere.org/arzdoura/.